Perché dobbiamo parlare
di famiglia
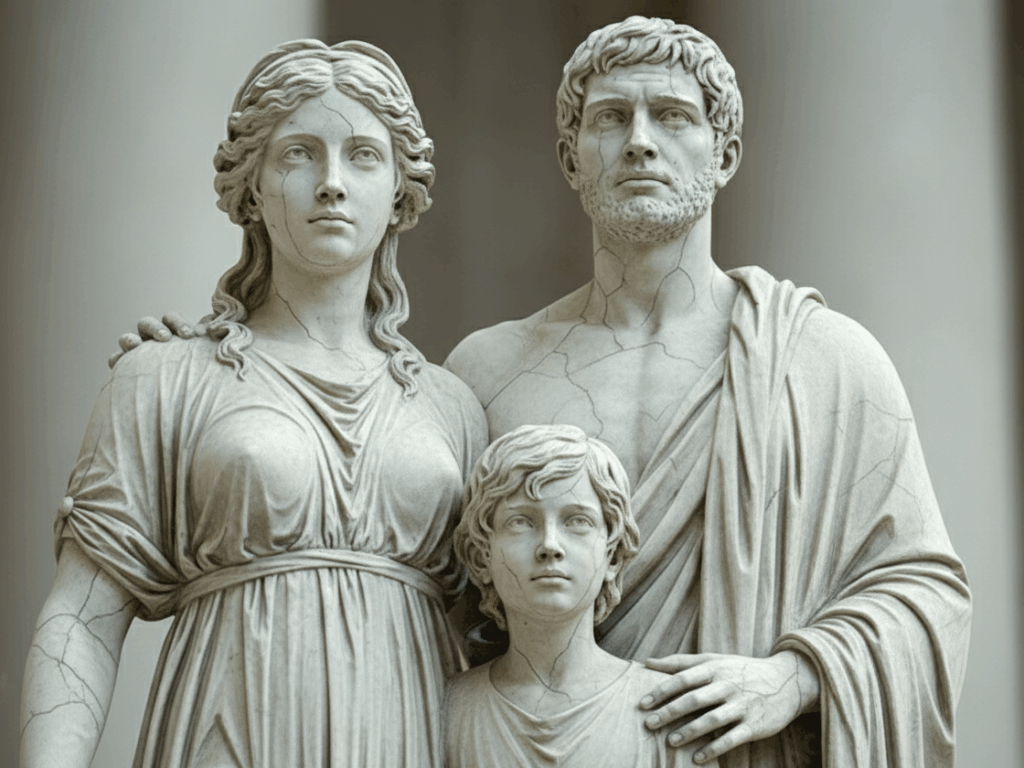

Marina Terragni
La generazione dei cosiddetti boomer, venuti al mondo quando tutti gli indicatori — dal benessere economico al numero delle nascite — viravano felicemente verso l’alto, si è formata in un clima di critica radicale della famiglia: lo psichiatra Ronald D. Laing che teorizzava sulla «famiglia schizofrenogena», David Cooper con il suo bestseller La morte della famiglia (1972), Michel Foucault che la includeva tra le istituzioni di disciplinamento.
Soprattutto negli anni 70 del ‘900 l’idea di superare la famiglia ha nutrito utopie e progetti di innovazione sociale contrastati solo da minoranze “tradizionaliste”. Ma il superamento dei legami familiari è stato anche obiettivo di progetti politici totalitari che vedevano nella famiglia un ostacolo al rapporto diretto tra i cittadini e lo Stato.
Il bilancio di questi percorsi storici è ambiguo e complesso: una “democratizzazione” della famiglia, da un lato, che in Occidente si è decisamente depatriarcalizzata (è del 1975 la riforma italiana del diritto di famiglia che ha affermato l’uguaglianza giuridica dei coniugi), anche se il disfarsi di quei codici millenari ha comportato ricadute inaspettate e dolorose come la violenta reazione maschile all’inaudito della libertà femminile. Nell’annunciare che «il patriarcato non ha più credito» la filosofa Julia Kristeva aveva avvisato che «la donna non ha di che ridere quando crolla l’ordine simbolico».
Dall’altro lato, va registrato il sostanziale fallimento dei progetti di convivenza alternativi, come la comune e altre sperimentazioni sociali: oggi le famiglie sono più fragili, rimpicciolite, isolate, prive del supporto di quel “villaggio” — la comunità — che da sempre ha costituito la mediazione tra il personale dei legami affettivi e l’impersonale dello Stato. A quanto pare l’unica vera e consolidata alternativa alla famiglia è la crescente solitudine, cifra delle nostre società che ha indotto qualcuno a definire l’Occidente come «il Terzo Mondo delle relazioni».
Che cosa augurarci per il futuro delle nostre figlie e dei nostri figli? Una vita da individui perfetti, assolutamente liberi e sciolti da ogni legame? O la costruzione di un nucleo affettivo con tutte le sue fatiche?
Quel che è certo, per il loro presente l’augurio è che possano crescere in famiglie “sufficientemente buone”, adeguate a un compito educativo primario non delegabile ad altre agenzie.
Grande parte delle problematiche che oggi affliggono bambini e ragazzi, al centro dell’attenzione e del lavoro dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza — disturbi psicologici in aumento ma anche eccesso di neurodiagnosi fin dalla prima infanzia; problemi di salute fisica e mentale e disturbi dell’apprendimento e del comportamento conseguenti all’accesso precoce e sregolato al digitale; abusi e violenza assistita — può essere ricondotta alle fatiche della famiglia.
Proprio per questo l’Autorità garante in questa occasione ha scelto di occuparsi di famiglie: delle loro difficoltà, delle loro disfunzionalità, della crescente conflittualità. Tenendo al centro la necessità di supportarle nel loro prezioso e difficile lavoro. Buona lettura.



