La fragilità delle famiglie
Infinity – stock.adobe.com – Realizzato con supporto IA
«In passato i nuclei familiari si comportavano e si organizzavano in base a regole condivise nella comunità di cui facevano parte» risponde Massimo Ammaniti, psicoanalista e neuropsichiatra infantile. «I genitori si sentivano sostenuti da un sistema semantico comune, il che aveva aspetti positivi ma anche negativi. La struttura della famiglia era patriarcale. Oggi quel patriarcato non esiste più e le famiglie sono molto diverse. In più di metà dei casi si mette al mondo un solo figlio che, in media, arriva piuttosto tardi, quando la madre ha superato i 30 anni, e magari dopo percorsi medici per riuscire a concepirlo.
Incide anche una maggiore autodeterminazione degli individui che compongono la famiglia, il che rende molto complicato per i genitori farsi valere. Il figlio viene coinvolto fin dall’inizio nelle dinamiche dei genitori e manca il sottosistema dei fratelli. Il rischio, quindi, è che non vi sia più una differenziazione generazionale: gli adulti della famiglia in qualche modo si infantilizzano – infatti si parla di adultescenti – e corrispettivamente i minori sono costretti ad adultizzarsi precocemente».
«La psicoanalisi ci ha insegnato che in adolescenza si verifica una riattivazione dei conflitti edipici. Ma oggi i genitori restano sullo sfondo rispetto al gruppo dei pari e questo complica notevolmente la dinamica». Altre agenzie educative possono surrogare le funzioni che la famiglia non riesce più a garantire? Per esempio: vietare lo smartphone a scuola quando magari i genitori ne sono dipendenti e lo usano compulsivamente in presenza del bambino? Oppure insegnare l’“affettività” quando la personalità del bambino è ormai strutturata? “Sicuramente la scuola deve fare la sua parte. Lì gli smartphone non devono entrare, ne sono convinto da sempre. Quanto all’educazione affettiva, mi pare che persista un equivoco: che cos’è? Chi la impartisce? Pensiamo di poter spiegare i sentimenti a ragazzi che vedono tutto online, pornografia compresa?
La regolazione affettiva si verifica nei primissimi anni di vita e le famiglie più fragili vanno supportate in questa fase della vita del figlio, meglio ancora se a partire dagli ultimi mesi della gravidanza, specialmente in caso di condizioni socio- ambientali di svantaggio, quando si manifestino cattive dinamiche relazionali nella coppia, o vi sia depressione materna. L’home visiting, questo il nome della pratica che consiste in un supporto domiciliare, è un programma di prevenzione precoce che ha mostrato di dare buoni risultati. Supportando la madre e il padre si aiuta il bambino a strutturarsi dal punto di vista affettivo. Del resto le stesse competenze genitoriali sono determinate anche dal tipo di accudimento ricevuto nella propria infanzia. A scuola non parlerei di educazione all’affettività, può essere invece interessante discutere delle dinamiche del gruppo classe, discussione che non dovrebbe essere condotta con l’ausilio di psicologi ma dagli stessi insegnanti”.
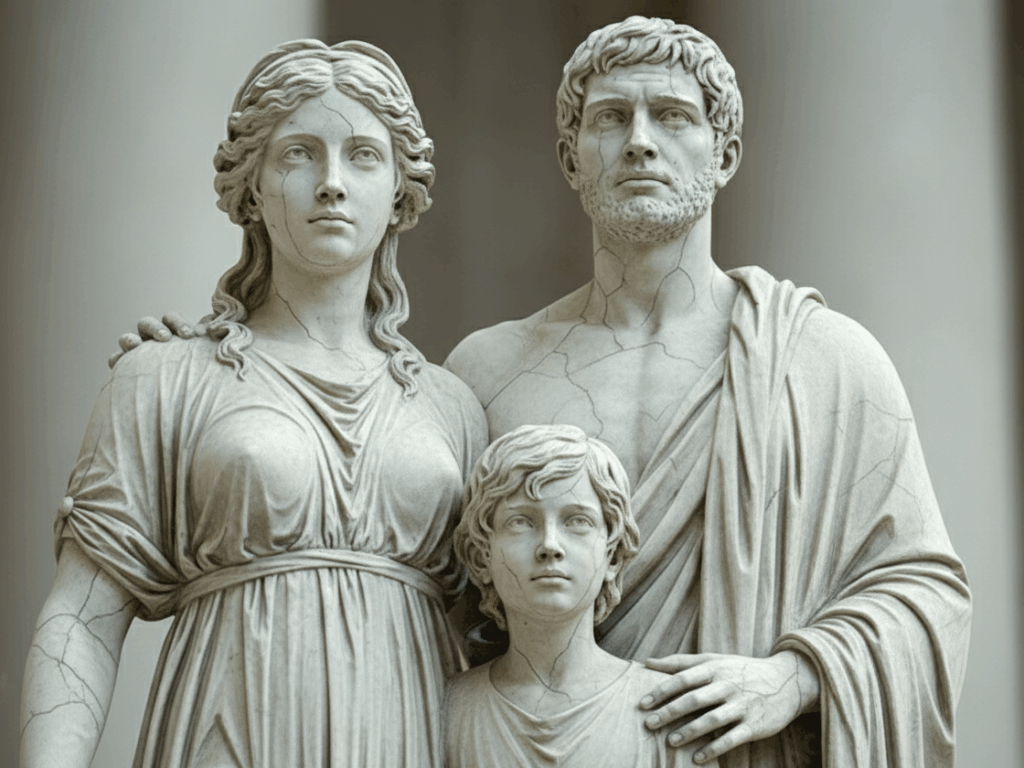
Realizzato con supporto IA
«Sicuramente la scuola deve fare la sua parte. Lì gli smartphone non devono entrare, ne sono convinto da sempre. Quanto all’educazione affettiva, mi pare che persista un equivoco: che cos’è? Chi la impartisce? Pensiamo di poter spiegare i sentimenti a ragazzi che vedono tutto online, pornografia compresa? La regolazione affettiva si verifica nei primissimi anni di vita e le famiglie più fragili vanno supportate in questa fase della vita del figlio, meglio ancora se a partire dagli ultimi mesi della gravidanza, specialmente in caso di condizioni socio-ambientali di svantaggio, quando si manifestino cattive dinamiche relazionali nella coppia, o vi sia depressione materna.
L’home visiting, questo il nome della pratica che consiste in un supporto domiciliare, è un programma di prevenzione precoce che ha mostrato di dare buoni risultati. Supportando la madre e il padre si aiuta il bambino a strutturarsi dal punto di vista affettivo. Del resto le stesse competenze genitoriali sono determinate anche dal tipo di accudimento ricevuto nella propria infanzia. A scuola non parlerei di educazione all’affettività, può essere invece interessante discutere delle dinamiche del gruppo classe, discussione che non dovrebbe essere condotta con l’ausilio di psicologi ma dagli stessi insegnanti».
«Non sempre i genitori di questi ragazzi si rendono conto per tempo di quello che succede ai figli. Spesso sottovalutano una tendenza all’ipercontrollo e alla possessività estrema, si pensa che la gelosia sia una componente ineliminabile o perfino auspicabile dell’amore.
Capita quindi che famiglie non sappiano leggere i segnali: la madre di uno degli autori della strage di Colombine ha scritto un libro in cui ammette di non essersi resa conto di nulla. I ragazzi violenti non provengono necessariamente da nuclei deprivati e svantaggiati: ci sono bambini che anche in una situazione difficile sanno sviluppare una loro resilienza e ce la fanno;
e magari altri che hanno avuto opportunità ben maggiori ma che devono fare i conti con una fragilità di base. I fattori in gioco sono diversi. Nelle dinamiche di ipercontrollo agisce spesso un’incapacità di accettare la separazione che viene vissuta come una catastrofe del sé; ma ci sono anche aspetti paranoidei, come l’idea che la tua ex rida di te con il suo nuovo partner. In generale l’individualità dell’altro è vissuta come una minaccia per se stessi».
«Padre e madre non sono figure uguali e interscambiabili.
La questione va vista sempre in termini triadici, tenendo conto delle notevoli differenze tra i ruoli».
«Lavoro da tempo su questo tema insieme a Monsignor Ravasi al Cortile dei Gentili, luogo di dialogo tra credenti e non credenti. Un terzo dei giovani dopo i 30 anni guadagna meno di mille euro, il lavoro è spesso precario, ci sono grossi problemi abitativi… Solo il 50% dei giovani scommette sul fatto che per loro ci sarà un futuro. Manca lo slancio, quel poco di follia che ti spinge a vivere l’avventura di un figlio. I figli vengono vissuti solo come un ulteriore ostacolo, una limitazione. È un problema drammatico e non solo in Occidente: oggi in Cina le cose non vanno diversamente. Una sorta di suicidio della specie».
«Hanno ragione. Dobbiamo investire tutto sui primissimi anni di vita: attenzione, risorse, competenze, lo ha detto perfettamente il premio Nobel per l’Economia James Heckman. Questo investimento costituisce un enorme risparmio sociale: intervenire dopo è dispendiosissimo per la società e per gli individui e spesso è inutile.
Se un ragazzo uccide una ragazza i costi sociali e umani sono enormi. Si deve insistere molto sul supporto alle famiglie, sull’home visiting ai nuclei in maggiori difficoltà e già a partire dalla gravidanza».


